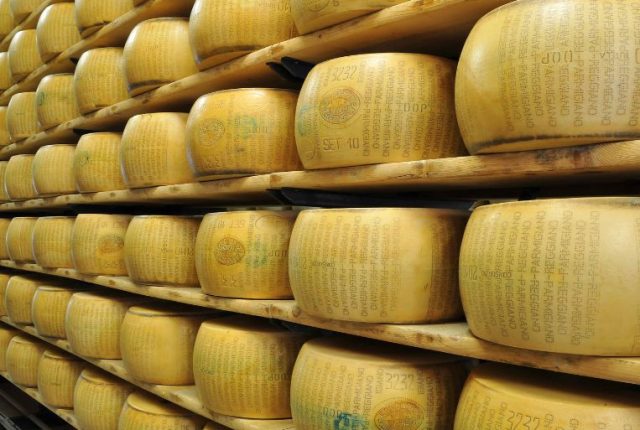Il vocabolo di origine greca “autoctono” unisce il senso di appartenenza (autós) alla terra (chtón) e viene riferito – secondo la Treccani – alle popolazioni stanziate in un determinato territorio da epoca tanto remota da ritenersi nate dalla terra medesima. È questo stesso profondo legame con l’anima antica di un territorio che affascina nei vitigni autoctoni, capaci di raccontare storie che hanno dentro comunità, radici antiche, emozioni e momenti importanti. Accade così che ogni denominazione del vino, in Italia, trovi un’incarnazione peculiare legata a vitigni che hanno modellato il paesaggio e condizionato l’approccio vitivinicolo. E poche regioni come l’Emilia-Romagna possono vantare un’ampiezza considerevole di espressioni enoiche declinata anche con numeri importanti.
Ecco che percorrere le Strade dei vini e dei sapori dell’Emilia-Romagna diventa un’esperienza sfaccettata da fare lentamente per scoprirne le differenze, rispondendo a una domanda di turismo enogastronomico di qualità sempre più interessata a conoscere i segreti e le eccellenze dei diversi areali, la loro storia e le loro tradizioni. In questo mosaico di etichette e calici, nel quale l’offerta vinicola è legata a doppio filo allo straordinario patrimonio gastronomico, osti e sommelier hanno a disposizione un ventaglio di proposte che ha la propria spina dorsale nei quattro vitigni simbolo della viticoltura emiliano-romagnola: Albana, Lambrusco, Malvasia di Candia e Sangiovese. Quattro “alfieri” che hanno fatto conoscere i rispettivi territori nel mondo, grazie soprattutto alla personalità duttile e alla capacità di raccontare nel proprio Dna l’incredibile varietà delle terre in cui hanno trovato la propria culla ideale.
Le sfumature eleganti dell’Albana
Le origini dell’Albana sono incerte, ma quel che è certo è che i Romani giocarono un ruolo chiave nell’affermazione e nello sviluppo di questo vitigno. Se non introdotto ex novo, fu sicuramente scoperto e valorizzato dai colonizzatori: il nome stesso è di origine latina, derivando dalla parola albus, traducibile con “chiaro” o “bianco per eccellenza”, in riferimento al colore chiaro delle uve Albana oppure al fatto che nell’impero era considerato il miglior vitigno a bacca bianca. Un’altra ipotesi fa risalire il nome ai Colli Albani, rilievi montuosi dell’Antiappennino laziale da dove proveniva il gruppo di legionari romani che ne avrebbero spinto la coltivazione. L’Albana è un vitigno romagnolo in senso stretto, dato che la Romagna è sostanzialmente l’unica area in cui viene allevato e utilizzato in vinificazione. In particolare, la varietà si esprime al meglio se coltivata sulle colline nei pressi della catena dello Spungone, una dorsale di roccia arenaria calcarea resistente all’erosione che si estende da Faenza a Cesena. I due versanti dello Spungone, che si caratterizzano per peculiari caratteristiche geologiche e la presenza di suoli argillosi con una componente calcarea variabile, accolgono vigneti collocati ad altitudini superiori ai 100 metri, dove l’Albana trova le condizioni ideali per esprimere le sue potenzialità. Primo vino bianco italiano insignito della Docg (nel 1987), il Romagna Albana ha dimostrato nel tempo una vocazione multiforme: fresco e beverino oppure portato ad appassimento per vini dolci e intensi, decisamente secco e quasi tagliente, o macerato a cercare un sorso materico, ma anche spumantizzato o rifermentato, il vitigno regge alle provocazioni della mano enologica. Il suo alleato più importante è però il tempo. Se infatti l’Albana ha attraversato la seconda metà del Novecento raccontata come un calice immediato e fresco, le sfumature più affascinanti emergono dopo qualche anno di bottiglia, quando l’acidità spiccata (e non ammorbidita da interventi in cantina) e una sapidità elegante fanno emergere toni di fiori essiccati, una mineralità con sentori quasi sulfurei e una persistenza del sorso che confermano le potenzialità di questi vini per un pubblico di consumatori consapevoli e attenti.
Il volto plurale dei Lambrusco
La desinenza “brusco” potrebbe identificarsi con la caratteristica tipica dei vini giovani e vivaci, dall’acidità spiccata e i tannini ruvidi, ma le interpretazioni filologiche sembrano più orientate a far risalire il nome Lambrusco alla propensione delle piante di vite a crescere spontaneamente ai bordi dei campi, maritandosi selvaticamente con gli alberi che segnavano i confini. Il Lambrusco è così legato al territorio emiliano da essere entrato da protagonista nelle vicende storiche. La leggenda vuole infatti che Matilde di Canossa, nel pieno della lotta per le investiture, vinse la battaglia di Sorbara grazie a uno stratagemma imperniato su questo vino. La Gran Contessa avrebbe infatti abbandonato il castello, assediato dalle truppe nemiche, lasciandone in dote una quantità sufficiente per inebriare e stordire i soldati, che a quel punto si sarebbero trovati incapaci di combattere. Al di là degli aneddoti, il Lambrusco è stato l’alfiere della produzione vitivinicola regionale, il ponte con i mercati di mezzo mondo e in particolare con quello americano, dove ha vissuto periodi di successo dirompente. Agile e frizzante, nella sua versione amabile ha inondato gli scaffali globali. Eppure, proprio quella enorme popolarità è stata un’arma a doppio taglio per il rosso charmat dell’Emilia, perché quando si distribuiscono milioni di bottiglie si rischia una sottovalutazione. Nel tempo però il Lambrusco ha ritrovato brio e fascino, grazie alla spinta di giovani produttori concentrati sul Lambrusco secco (pur senza abbandonare del tutto la tradizione della versione amabile) e alle pregevoli versioni Metodo classico che hanno conquistato i palati più esigenti. E contestualmente va riconosciuto al mondo del Lambrusco Doc di mettere in sinergia grandi e piccoli produttori, con le cooperative che seguono la traccia del valore, magari per i loro brand di nicchia. Un altro fenomeno che sta riportando il Lambrusco sulle tavole è la sottolineatura delle differenze. Sì, perché questo vino è plurale nelle tecniche di vinificazione, negli stili e nell’utilizzo dei vitigni – dal Salamino al Sorbara, dal Grasparossa al Marani, Maestri o Montericco – che portano nel calice espressioni peculiari e affascinanti.
Malvasia di Candia, aromatica e raffinata
Richiamando la città di Candia – storico capoluogo di Creta, il cui nome veniva utilizzato per indicare l’intera isola durante la dominazione veneziana tra il XII e il XVII secolo –, la Malvasia di Candia ha molto probabilmente origine in Grecia. Se è pur vero che i veneziani chiamavano “Malvasia” vini da uve differenti, questo vitigno aromatico è arrivato in Emilia e in Romagna portando con sé un bagaglio di espressività unico. Nei secoli, proprio la spiccata aromaticità è stata l’origine della sua celebrità, dato che storicamente non mancava di farsi riconoscere sulle tavole dei nobili signori. In tempi più recenti, però, questa peculiarità l’ha penalizzato perché dà vini molto caratterizzati e poco allineati rispetto al palato moderno. Il ritorno alla Malvasia oggi passa dalle interpretazioni più verticali e asciutte, che ne valorizzano la tensione e l’acidità senza violarne la personalità brillante. Tra i Colli Piacentini e le terre romagnole si possono così scoprire etichette da affiancare a un ragù di corte o alle animelle, a un salume Dop o a una minestra di legumi, senza timore di banalizzare l’accostamento di sapori.
Sangiovese, principe di Romagna
Come ogni pretesa etimologica nella storia della vigna e del vino, anche l’origine del nome Sangiovese risulta incerta, ma poiché si tratta del vitigno a bacca rossa più coltivato in Italia la vulgata ricostruisce un legame direttamente con Zeus. Il vino originato dalla santità o dal sangue del padre degli dei dell’antica Grecia, in terra Romana sarebbe diventato il sangue di Giove (sanguis Iovis), con un’accezione fortemente celebrativa. Al di là dell’agiografia, gli ampelografi ritengono che il luogo d’origine del Sangiovese sia la zona appenninica tra Toscana e Romagna, dove ancora oggi rappresenta l’uva a bacca rossa più importante. Rispetto ai biotipi che hanno attecchito in Toscana – il piccolo nel Chianti, il grosso a Montalcino, il prugnolo gentile nella zona di Montepulciano, il grossetano in Maremma –, il Sangiovese romagnolo si caratterizza per una espressione vitale e croccante nel calice. E questo vitigno dal carattere peculiare funge da interprete, nel calice, di territori differenti, portando in superficie sfumature intriganti proprio per la loro varietà. Sul Sangiovese è imperniato il progetto Rocche di Romagna che il Consorzio ha spinto per valorizzare le specificità dei territori di Bertinoro, Brisighella, Castrocaro, Cesena, Coriano, Imola, Longiano, Marzeno, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Oriolo, Predappio, San Clemente, Serra e Verucchio, portandoli in etichetta. Il marchio collettivo, che riunisce tutte le sottozone della denominazione Romagna Sangiovese, mette in bottiglia vini che in alcune sottozone godono di una scarna eleganza minerale e in altre spingono sul volume, con tannini più o meno raffinati, regalando un frutto che in talune aree risulta più polposo e in altre più sottile.