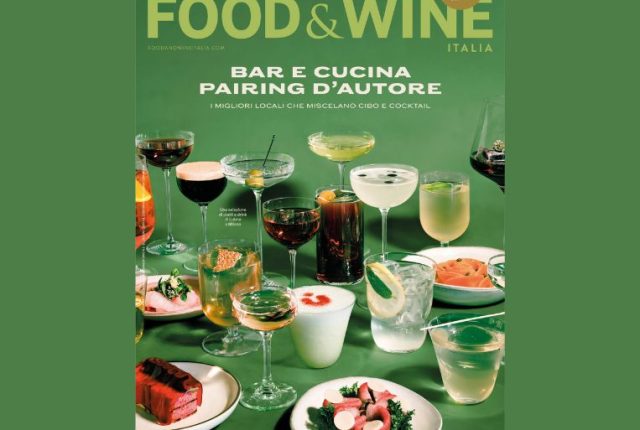Un piccolo borgo, che qualcuno faticherebbe a collocare sulla cartina geografica, affascinante per storia e per profili, laddove tutto ancora sembra disegnarsi intorno a uomo e natura, distante dallo sviluppo schizofrenico che ha stravolto simili realtà, magari in nome del tanto agognato turismo. Una denominazione altrettanto piccola e altrettanto storica, la prima dell’Umbria, la quinta in Italia, a tutelare un vino (base Sangiovese per il rosso, Trebbiano per il bianco) che ha segnato la storia enologica dell’intero Paese e può continuare a farlo, fedele al proprio carattere, a dispetto della succitata follia cui talvolta indurrebbe il mercato.
Portano lo stesso nome, Torgiano, ed è quello della cittadina fortificata laddove i corsi dei fiumi Tevere e Chiascio vedono unire le loro acque, le loro valli. E laddove vissero gli etruschi, probabilmente i primi a intentare la bonifica delle paludi residuali del lago Tiberino, i cui lasciti sono tuttora presenza benevola per chi lavora la terra di queste campagne.
Una famiglia e un territorio
Il racconto di questo territorio, delle sue viti e del suo vino, è legato in maniera indissolubile a quello della famiglia Lungarotti. In primis alla figura di Giorgio, uomo di volontà, visione, intuizioni e gusto, straordinari, cui tutta la comunità riconosce un ruolo cruciale. Il primo rimando alla sua memoria, passeggiando con la figlia Chiara, sono le balze vitate che vedono gli olivi a marcarne i confini, «in continuità con quelle che un tempo erano le viti maritate. E soprattutto a evitare uno spreco di spazio, cosa che mio padre non tollerava». Siamo sui saliscendi della collina di Brufa, tra le due valli, Perugia da una parte e Assisi dall’altra, ed è qua che dimora la mitica vigna Monticchio, 300 metri di altitudine e orizzonti aperti, terra viva ed erba verde tra i filari, Sangiovese che ha fatto la storia dell’Umbria. «La prima etichetta del Rubesco è del 1962, il nome lo suggerì mia madre da rubescere, ovvero arrossire. Già due anni dopo nasceva la Riserva Vigna Monticchio», un cru ante litteram che Giorgio aveva immaginato viaggiando nei territori dell’eccellenza, confrontandosi coi pionieri del tempo.
La serie di date da citare sarebbe lunghissima, a corrispondere con quelli che sono i traguardi della vitivinicoltura regionale e del movimento a essa legato: nel 1977 la vendemmia di debutto per il San Giorgio, primo “super-Umbrian” con apporto del Cabernet Sauvignon, nel 1981 la fondazione del Banco d’assaggio dei vini d’Italia, nel 1994 la nascita dell’agriturismo. Nel 1996 vennero installate le prime centraline meteorologiche nei vigneti – «passo fondante per una politica di tutela ambientale. Su questo continuiamo a investire, in vigna come in cantina», continua Chiara – dove le grandi botti in rovere sono emblema della filosofia produttiva e dove la stabilizzazione a freddo consente un basso utilizzo di solforosa aggiunta. Nella vasta gamma di vini prodotti, Torre di Giano resta l’icona di Torgiano in bianco, da uve Vermentino, Grechetto e Trebbiano, Vigna il Pino la sua esaltazione dal colle più vocato, mentre il già citato Vigna Monticchio è l’alfiere in rosso: un Sangiovese “torgianese” (prima in blend col Canaiolo, oggi in purezza) sempre in equilibrio tra profondità e finezza, freschezza e austerità, con una sorprendente nota marina e una commovente longevità. A guidare l’azienda è tutto’ra la famiglia Lungarotti: Chiara, la sorella Teresa coi figli Gemma e Francesco, mentre Maria Grazia, la moglie di Giorgio, è ben più che memoria storica (sta lavorando a un preziosissimo libro), delicata quanto intransigente nel guardare al futuro.
Sodalizio tra vino e legno
Continuando a parlare di identità, la famiglia Margaritelli vede specchiarsi la propria nel mondo del legno, settore in cui da generazioni è protagonista del mercato. Nel 1950 fu Fernando che per diletto cominciò a produrre vino, nel 2000 suo figlio Giuseppe riqualificò la proprietà sulla collina di Miralduolo, dando luce all’azienda vitivinicola Terre Margaritelli, oggi in pieno regime biologico. «Solo conoscendo la nostra storia si può capire lo straordinario rapporto legno-vino che caratterizza la produzione vinicola, fino a farsi tratto distintivo», come raccontano Dario Margaritelli e Federico Bibi, suo braccio destro in azienda. Tutto riconduce alla Borgogna, a una segheria costruita negli anni 60 per la produzione di traverse ferroviarie, a studi e mappature focalizzate sulla relazione legno/ vino. Che individuano nella foresta di Bertrange la culla di un rovere «dal profilo delicato, con note balsamiche mai coprenti, ideale per la produzione di barrique in linea con la nostra filosofia», sublimata con la recente acquisizione di una tonnellerie ad Allier.
Sembrerebbe un azzardo non prescindere (quasi) mai dalla piccola botte, ma proprio il suo utilizzo fin dalla fase di fermentazione fa sì che «non divenga mai un elemento di uniformità, ma che piuttosto vada a esaltare il frutto, evidenziandone le peculiarità. Del resto l’elemento chiave nel fare vino è la qualità dell’uva, che vogliamo altissima». Il progetto è ambizioso e prevede sforzi talvolta al limite del razionale, «ma un’impresa familiare non vive di soli numeri, vive anche di cuore», ribadisce Dario Margaritelli, e col vino nel bicchiere si torna a citare la Borgogna per i lunghi affinamenti commutati in «freschezza, equilibrio, bevibilità, che poi dovrebbe essere l’aspettativa di chi acquista Torgiano». Citiamo il bianco Greco di Renabianca da solo Grechetto, tutto in barrique, vivace manifesto di quanto raccontato finora. Ma pure il rosso Freccia degli Scacchi che è un Torgiano riserva da 100% Sangiovese, profumato e potente, mentre Pictoricius è immaginato sull’orizzonte del tempo: prodotto in 1.300 esemplari numerati, ha polpa e struttura, profondità: «Sarà perfetto da bere per chi verrà dopo di noi».
Calici di amicizia
Mani di Luna è una storia di amicizia, complice la musica, che dal 2012 fa riunire il perugino Rocco, il veneto Simone e il salentino Alessandro in quel di Torgiano. Non tanto in sala prove quanto presso una fattoria che ha base laddove il Chiascio confluisce nel Tevere, zona ventilata «con terreni sabbiosi, limosi, roccia in profondità», mentre altri appezzamenti stanno nel bosco della collina di Montesanto, coda dei monti Martani, fino ai 400 metri altitudine ed esposizioni che sovente guardano a nord-ovest. «Là i suoli sono più vari, differenziati per ogni vigna, con più argilla e più mineralità», racconta Alessandro; «ancora più in alto troviamo gli oliveti e altrove i ciliegi, intorno casa il grano e l’orto». Ci sono anche gli animali da cortile, «che nessuno riesce più ad ammazzare: oramai sono diventati amici anche loro».
L’obiettivo è l’autosufficienza, «sapere cosa coltiviamo e cosa mangiamo, nel rispetto della terra», affidandosi a una biodinamica vissuta come un credo, non certo come moda. Simone, che già lavorava qui quando le uve venivano conferite a terzi, ricorda quei grappoli di Trebbiano «così belli, cangianti, quasi rosa: perché non provare a vinificarli noi?». E così è stato. Si diraspa a mano, si pigia coi piedi, i vini fermentano spontaneamente «senza alcun additivo, se non un’idea di solforosa», evolvono in acciaio e cemento, adesso anche in terracotta, mai filtrati né chiarificati. La produzione di Mani di Luna si può riassumere in due filoni, «uno che guarda all’immediatezza, con macerazioni brevi e vini freschi, l’altra più legata al territorio», e da qui si estrae La Cupa, «il figlio più caro, sanguigno, sensibile e forte allo stesso tempo», selezione delle migliori uve di Sangiovese di Torgiano, materia e sostanza per un vino comunque «molto naturale e molto digeribile».
Tornando alla collina di Brufa
Le Tenute Baldo hanno due avamposti viticoli, uno a Cantalupo di Bevagna, in piena Doc Montefalco, «interpretata con fedeltà al territorio e ai suoi vitigni autoctoni», come racconta il titolare Mattia Casini, l’altra qui a Torgiano, per uve vinificate nella cantina di Bastia Umbra, «cercando un profilo più internazionale». I vigneti più vocati si trovano sulla collina di Brufa, madrina dei rossi Auravitae e Spirito della Vite, dove al Sangiovese si sposano Merlot e Cabernet Sauvignon. «Il secondo è la nostra riserva Docg, da uve selezionate e affinamento in legno», lirica quanto vigorosa, mentre il bianco si chiama Figlio della Luna, «perché Sauvignon e Chardonnay vengono vendemmiati di notte, così da preservarne gli aromi» che ben spalleggiano il Trebbiano.
Non distante, presso l’agriturismo Casale Villa Chiara, anche a Daniele Rossi è venuta voglia di vinificare le proprie uve. Così, dall’annata 2017, ha creato un’etichetta a suo nome e coadiuvato dalla moglie Romina mette in bottiglia il frutto di una campagna vivida, bella fin dal primo sguardo, con un percorso segnato verso il biologico. La freschezza è ancora una volta il dogma da perseguire, «quasi fisiologico, per accompagnare la sapidità dei nostri piatti, dai salumi ai formaggi». Grechetto, Trebbiano spoletino, poi di nuovo Sangiovese protagonista: Amdarò è il rosso di Torgiano Doc con apporto di Merlot, «giusta acidità a premiare il frutto», mentre il Montescosso è un Igt in cui le proporzioni si ribaltano e proprio il Merlot fa da padrone, l’affinamento in barrique diviene lungo e la struttura più importante.
Fine del giro, non della storia
È finito il giro, non la scoperta e tantomeno la storia, per questa denominazione «piccola, ma dall’identità ben chiara», per dirlo giusto con le parole di Daniele Rossi. Chi viene a Torgiano e beve Torgiano sa dove affondano le radici, quali sono le caratteristiche che nel tempo si sono preservate e rilanciate resistendo a mode e gusti passeggeri. Forti di questo, e di una produzione dalla qualità media notevole, i calici possono volare alto, viaggiare lontano, senza alcuna soggezione nei confronti di territori dai numeri ben più altisonanti.
Cinquant’anni di un museo che va oltre il vino
«Ci piace osservare lo stupore sul volto di chi entra nel museo e vi trova ciò che non immaginava di trovare». È con grande emozione che Teresa Severini, al fianco della madre Maria Grazia Marchetti Lungarotti, introduce al Muvit, il Museo del vino di Torgiano che va compiendo cinquant’anni di storia. Il New York Times lo etichettò come “il migliore in Italia” per le sue collezioni artistiche, il che già ci dà un’indicazione, anche sullo stupore cui accenna Teresa: reperti archeologici e attrezzi per la vitivinicoltura, anfore e contenitori di varie epoche ma anche testi, incisioni, disegni, sculture, tessuti che al vino sono legati, ispirati. Il mondo del vino e il vino del mondo, a testimoniare la sua centralità «nell’economia come nella società, nell’immaginario dei popoli che hanno abitato il Mediterraneo e l’Europa continentale nel corso dei millenni».
Si parte quindi da Torgiano e dalla famiglia Lungarotti, che il museo lo ha fondato e guidato, ma si approda a 5mila anni di storia, agli etruschi come ai greci, ai romani e al contemporaneo, «poiché contemporanea è l’esperienza in cui lo viviamo». Se un messaggio emerge, oltre alla meraviglia della testimonianza, è il richiamo a «bere con gioia, consapevolezza e moderazione»: oltre la misura, si annida sempre il demone dell’oblio. Oggi sono 20 le sale allestite all’interno del già suggestivo Palazzo Graziani-Baglioni, dimora gentilizia del XVII secolo, in questi mesi impreziosite da un percorso fotografico che sintetizza la storia “umana” di cinquant’anni di museo.